Una parola, un verso: trentaduesima – matto
- Senti, - disse l’ometto – io non sono mica giusto.
- Cos’ha?
- Sono matto.
Si mise il berretto. Nick aveva voglia di ridere.
- Lei sta benissimo – disse.
- No, non è vero. Sono matto. Di’, sei mai stato matto, tu?
- No, – disse Nick – com’è quando si diventa matti?
- Non lo so, - disse Ad- quando sei diventato matto, mica lo sai come lo sei diventato. Tu mi conosci, no?
- No.
Questo irresistibile scambio è estratto da un racconto di poche pagine di Ernest Hemingway, intitolato Il lottatore del 1938 e racchiude in sé, con la maestria difficilmente inarrivabile di Hemingway autore di racconti, tutto quello che c’è da sapere sull’essere matto, ossia nulla, nulla di veramente spiegabile. Perché, chi decide che quel comportamento, quella parola, quel tono di voce, quel gesto siano indice chiaro di pazzia?
Perché se l’Ad del racconto di Hemingway sceglie di accogliere uno sconosciuto intorno al suo fuoco e poi divide con lui il suo cibo è subito identificato come “generoso”, ma se poi cambia repentinamente idea o forse non del tutto e comunque lo sfida a fare a pugni, a colpirlo, a ferirlo, diventa improvvisamente “matto”? Lo sarebbe stato meno se avesse confezionato per noi lettori una quadrata ragione? Ma chi stabilisce quale ragione sia migliore o semplicemente più accettabile di un’altra? Hemingway ce ne offre una (un amore negato), eppure già mentre la sta offrendo ai nostri occhi, la distorce a tal punto da non consentirci di credere alla storia di Ad o comunque a non ritenerla degna di giustificare appieno il suo comportamento. Ma è qui il mirabile e palese inganno dello scrittore, che ci fornisce una pista talmente ovvia e al contempo surreale (il matrimonio fallito di Ad con una donna che sembrava sua sorella tanto gli assomigliava, ma non lo era, eppure solo il sentore dell’anormalità li aveva ghettizzati, spingendo lei a lasciarlo) da impedire al lettore di trovare in essa una rassicurazione a buon mercato. Usciamo fuori dal racconto, senza uscirne mai del tutto, non potendo più illuderci che sia possibile discernere il “sano” da “matto”, il “giusto” dallo “sbagliato”. Quando rileggo questo racconto, il pensiero va a un film di Giuseppe Tornatore, il film di Tornatore, ossia Nuovo cinema Paradiso (1988). Uno dei personaggi minori che più ho amato all’interno del paesaggio umano che Tornatore crea rielaborando la sua memoria è il matto del paese. Ve lo ricordate? Sostiene per anni che la piazza centrale sia di sua proprietà, anche quando le automobili avranno preso il posto delle persone, lasciandogli ben poco spazio da presidiare e conservare.
Cosa ci permette di definirlo “matto” e non “romantico”, “sognatore”, “catalizzatore delle paure altrui” o semplicemente “diverso”, qualcuno che diffonde le emozioni, anziché rifletterle (vedi lett.e. della definizione a fine articolo)?
Bisognerebbe chiedere ad Ad, lui una risposta di certo ce la darebbe, ma servirebbe solo a metterci ancora più in difficoltà e queste sono le risposte migliori.
Una parola, un verso: trentaduesima – matto
agg. e s. m. (f. -a) [forse lat. tardo mattus, matus «ubriaco»].
a. ant. Stupido, stolto b. Nell’uso mod., di persona che non possiede, o non possiede interamente, l’uso della ragione c. estens. Persona bizzarra, stravagante, o spensieratamente allegra d. In senso fig., come agg., di persone che, per un qualsiasi motivo, si comportano in modo simile a chi non ha l’uso della ragione. e. opaco, che diffonde la luce, anziché rifletterla.
Fonte: Vocabolario Treccani
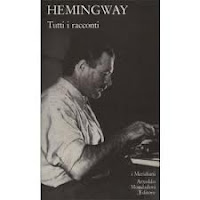




Commenti
Posta un commento